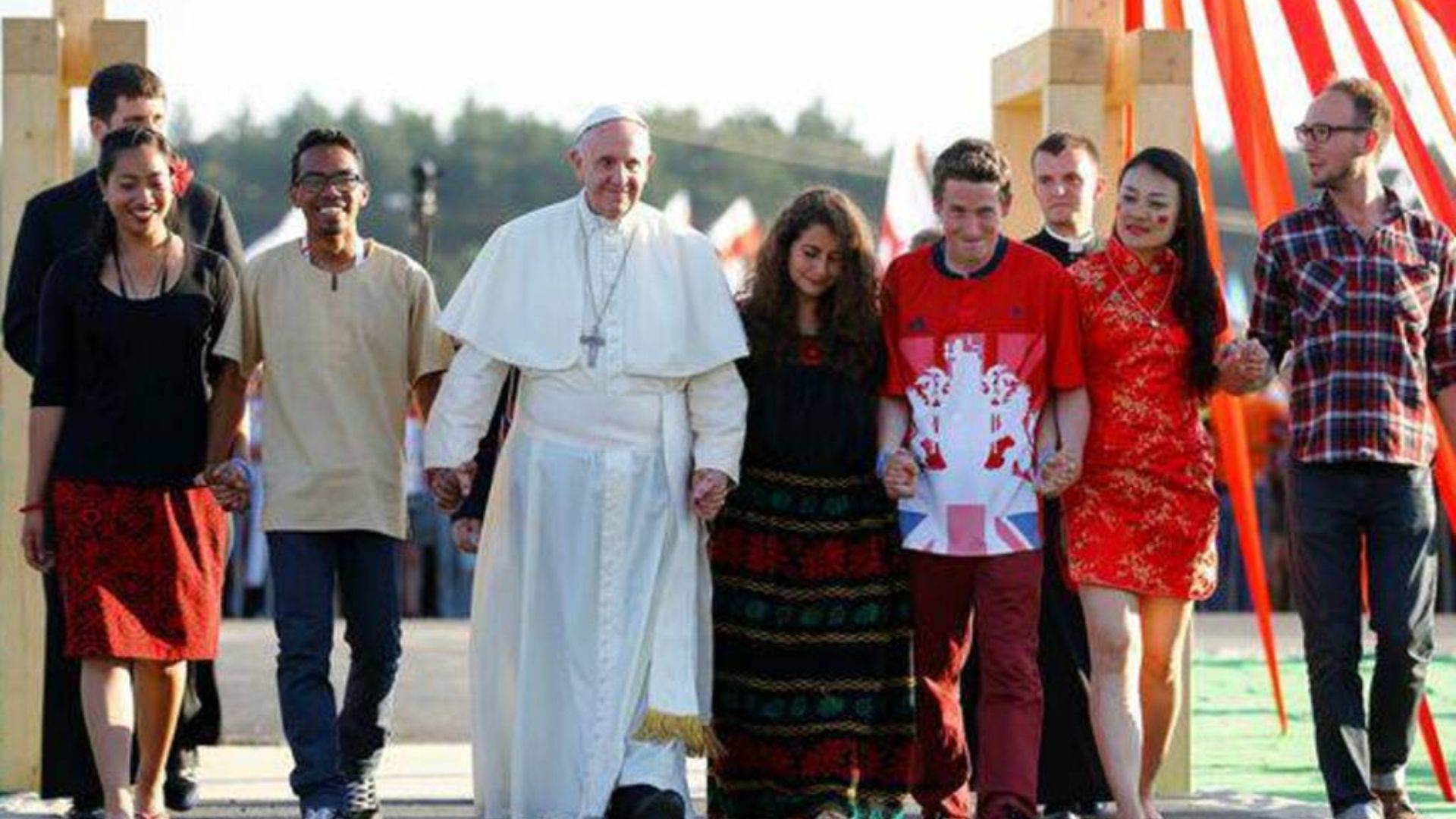Da NPG di luglio e agosto, l’editoriale di don Rossano Sala.
***
Eccoci alla quarta tappa del nostro percorso di riscoperta e valorizzazione dei dinamismi virtuosi e delle prospettive generative del Sinodo sui giovani[1]. In conformità e in continuità con alcuni contributi del Dossier che segue sull’animazione biblica della pastorale giovanile, proviamo a puntare la nostra attenzione su una coppia interessante che caratterizza lo stile specifico del nostro tempo e in particolare del mondo giovanile di avvicinarsi alla trascendenza, al sacro, a Dio: in termini ampi possiamo parlare di “religione” e “spiritualità”. Con il primo termine intendiamo qui prima di tutto un’appartenenza ad una istituzione a cui si è legati attraverso una partecipazione più o meno fedele, con il secondo invece abbiamo più a che fare con una connessione diretta e personale con la trascendenza, non mediata da un’istituzione religiosa specifica e identificata socialmente.
Nelle varie tappe del cammino sinodale, fatto di ascolto e discernimento, questa polarità è stata oggetto di varie riflessioni, che qui conviene almeno riprendere per sommi capi.
Un primo passaggio
Nell’Instrumentum laboris è stata lasciata la parola ai giovani e ne è stato riportato il pensiero su molti argomenti, tra cui questo del rapporto tra “spiritualità” e “religiosità”. Ecco un passaggio introduttivo che ci avvicina al nostro tema:
Come ha evidenziato la Riunione presinodale, la varietà è la cifra che meglio esprime anche il rapporto dei giovani nei confronti della fede e della pratica religiosa. In generale si dichiarano aperti alla spiritualità, anche se il sacro risulta spesso separato dalla vita quotidiana. Molti ritengono la religione una questione privata e si considerano spirituali ma non religiosi (nel senso di appartenenti a una confessione religiosa) (cfr. Riunione presinodale, 7). La religione non è più vista come la via di accesso privilegiata al senso della vita, ed è affiancata e talvolta rimpiazzata da ideologie e altre correnti di pensiero, o dal successo personale o professionale (cfr. Riunione presinodale, 5)[2].
Si tratta di un input iniziale che si ritrova anche nel rapporto dei giovani con la persona di Gesù, il quale si ritrova ancora sotto la cifra della molteplicità:
La stessa varietà si riscontra nel rapporto dei giovani con la figura di Gesù. Molti lo riconoscono come Salvatore e Figlio di Dio e spesso gli si sentono vicini attraverso Maria, sua madre. Altri non hanno con Lui una relazione personale, ma lo considerano come un uomo buono e un riferimento etico. Per altri è una figura del passato priva di rilevanza esistenziale, o molto distante dall’esperienza umana (così come distante è percepita la Chiesa). Le false immagini di Gesù lo privano di fascino agli occhi dei giovani, così come una concezione che considera la perfezione cristiana come al di là delle capacità umane conduce a considerare il cristianesimo uno standard irraggiungibile (cfr. Riunione presinodale, 6). In diversi contesti i giovani cattolici chiedono proposte di preghiera e momenti sacramentali capaci di intercettare la loro vita quotidiana, ma occorre riconoscere che non sempre i pastori sono capaci di entrare in sintonia con le specificità generazionali di queste attese[3].
La richiesta va già nella direzione per cui l’istituzione ecclesiale è chiamata prima di tutto ad impegnarsi a fondo nel tenere aperta la connessione tra religione e spiritualità, aiutando i giovani attraverso iniziative di preghiera e momenti sacramentali a collegare l’istituzione ecclesiale sia con Gesù che con la vita di ogni giorno.
Un secondo passaggio
Il discernimento durante il mese dell’Assemblea sinodale (3-28 ottobre 2018) ci ha restituito una ricchezza di approfondimenti e stimoli sul tema. Prima di tutto occorre notare che il panorama mondiale è evidentemente ricco e articolato, perché influenzato dal contesto sociale e culturale in cui i giovani vivono[4].
Il denominatore comune sembra ormai essere la “ricerca”, che rimane una base condivisa nel mondo giovanile, in particolare nei paesi dove la secolarizzazione si fa maggiormente sentire, perché «nelle società secolari assistiamo anche a una riscoperta di Dio e della spiritualità. Questo costituisce per la Chiesa uno stimolo a recuperare l’importanza dei dinamismi propri della fede, dell’annuncio e dell’accompagnamento pastorale»[5]. I Padri sinodali così sintetizzano le discussioni intorno al tema:
In generale i giovani dichiarano di essere alla ricerca del senso della vita e dimostrano interesse per la spiritualità. Tale attenzione però si configura talora come una ricerca di benessere piscologico più che un’apertura all’incontro con il Mistero del Dio vivente. In particolare in alcune culture, molti ritengono la religione una questione privata e selezionano da diverse tradizioni spirituali gli elementi nei quali ritrovano le proprie convinzioni. Si diffonde così un certo sincretismo, che si sviluppa sul presupposto relativistico che tutte le religioni siano uguali. L’adesione a una comunità di fede non è vista da tutti come la via di accesso privilegiata al senso della vita, ed è affiancata e talvolta rimpiazzata da ideologie o dalla ricerca di successo sul piano professionale ed economico, nella logica di un’autorealizzazione materiale. Rimangono vive però alcune pratiche consegnate dalla tradizione, come i pellegrinaggi ai santuari, che a volte coinvolgono masse di giovani molto numerose, ed espressioni della pietà popolare, spesso legate alla devozione a Maria e ai Santi, che custodiscono l’esperienza di fede di un popolo[6].
E qui viene ancora alla luce la centralità del Signore Gesù, vista e vissuta in una certa contrapposizione con un percorso ecclesiale istituzionale, che viene in molte occasioni considerato dai giovani un vero e proprio ostacolo alla relazione personale con Lui:
Se per molti giovani Dio, la religione e la Chiesa appaiono parole vuote, essi sono sensibili alla figura di Gesù, quando viene presentata in modo attraente ed efficace. In tanti modi anche i giovani di oggi ci dicono: «Vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21), manifestando così quella sana inquietudine che caratterizza il cuore di ogni essere umano: «L’inquietudine della ricerca spirituale, l’inquietudine dell’incontro con Dio, l’inquietudine dell’amore» (Francesco, Santa Messa per l’inizio del Capitolo Generale dell’ordine di sant’Agostino, 28 agosto 2013)[7].
Un terzo passaggio
Nella Christus vivit il tema del rapporto tra religione e spiritualità non si sviluppa in termini teorici, ma attraverso spunti pratici e operativi. Papa Francesco, conformemente al suo stile personale che si fa linguaggio diretto e coinvolgente, invita i giovani a vivere una spiritualità incarnata: «La tua crescita spirituale si esprime soprattutto nell’amore fraterno, generoso, misericordioso»[8]. E li spinge a rimanere sempre connessi con Gesù:
Molti giovani si preoccupano del proprio corpo, cercando di sviluppare la forza fisica o l’aspetto. Altri si danno da fare per potenziare le loro capacità e conoscenze, e in questo modo si sentono più sicuri. Alcuni puntano più in alto, si sforzano di impegnarsi di più e cercano uno sviluppo spirituale. San Giovanni diceva: «Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la Parola di Dio rimane in voi» (1Gv 2,14). Cercare il Signore, custodire la sua Parola, cercare di rispondere ad essa con la propria vita, crescere nelle virtù, questo rende forti i cuori dei giovani. Per questo occorre mantenere la “connessione” con Gesù, essere “in linea” con Lui, perché non crescerai nella felicità e nella santità solo con le tue forze e la tua mente. Così come ti preoccupi di non perdere la connessione a Internet, assicurati che sia attiva la tua connessione con il Signore, e questo significa non interrompere il dialogo, ascoltarlo, raccontargli le tue cose, e quando non hai le idee chiare su cosa dovresti fare, domandagli: «Gesù, cosa faresti Tu al mio posto?»[9].
E chiede anche alla Chiesa di recuperare questa umanità, familiarità, confidenza e ferialità con i giovani. Che sia sempre meno fredda e distaccata istituzione e sempre più casa spirituale e accogliente dove poter vivere relazioni significative con Dio e tra di noi. Il cuore della Chiesa non può che essere spirituale, ed il suo volto istituzionale dovrebbe custodire esattamente questo, come si fa con un tesoro custodito in vasi di creta[10]:
Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla sul passato, frenarla, renderla immobile. Chiediamo anche che la liberi da un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le offre, credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con gli altri. No. È giovane quando è sé stessa, quando riceve la forza sempre nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo e della forza del suo Spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamente alla sua fonte[11].
Due considerazioni finali
Dopo questa breve carrellata attraverso nei tre documenti fondamentali del cammino sinodale con e per i giovani, rilanciamo con due brevi semplici annotazioni, che possono diventare degli orientamenti pastorali precisi. La prima dice che allontanarsi dalla Chiesa come istituzione non significa smettere di credere, cercare, amare. È invece da notare che talvolta vale il suo contrario:
La maggior parte dei giovani che hanno abbandonato la Chiesa non si allontana dalla fede, ma mette da parte il coinvolgimento nella comunità o parrocchia, perché ha meno difficoltà con la fede in Cristo che con l’esperienza della Chiesa. Essi hanno chiuso con la Chiesa, perché sono stanchi della Chiesa: “Sono insoddisfatti della struttura, del messaggio sociale e della politica della Chiesa istituzionale, e hanno deciso che le loro vite spirituali vanno meglio se vissute al di fuori della religione organizzata”. Molti, infatti, considerano il fatto di lasciare la Chiesa come l’unico modo per salvare la loro fede[12].
Sono parole forti, ma ci dovrebbero aiutare a verificare qual è il volto della Chiesa con cui ci presentiamo ai giovani e quale Chiesa stiamo consegnando loro. E arriviamo infine alla seconda annotazione, che dice quanto il desiderio di comunione, di fraternità e di relazione abita intimamente il mondo giovanile attuale, che appare in una vera e propria situazione di “orfanità”. Senza una Chiesa adulta che sappia offrire maternità e paternità autentiche non si andrà molto lontano e i giovani rischiano di rimanere
orfani di strade sicure da percorrere, orfani di maestri di cui fidarsi, orfani di ideali che riscaldino il cuore, orfani di valori e di speranze che li sostengano quotidianamente. Vengono riempiti magari di idoli ma si ruba loro il cuore; sono spinti a sognare divertimenti e piaceri, ma non si dà loro il lavoro; vengono illusi col dio denaro, e negate loro le vere ricchezze[13].
Il volto familiare della Chiesa va sempre di nuovo riconquistato: essere e diventare “casa” rimane un dono e una chiamata per la Chiesa di tutti i tempi, anche per la nostra. Casa in cui si dimora volentieri, in cui i giovani si sentono accolti, adottati, partecipi e corresponsabili.
NOTE
[1] Le prime tre tappe sono i tre editoriali del 2025: Cfr. R. Sala, Respirare a due polmoni. L’importanza dell’ascolto e i dinamismi del discernimento, in «Note di pastorale giovanile» 1 (2025) 2-6; Id., Accompagnamento e annuncio. Uno stile ecclesiale per una necessità epocale, in «Note di pastorale giovanile» 2 (2025) 2-6; Id. Vocazione e missione. Il focus qualificante della proposta del Sinodo sui giovani, «Note di pastorale giovanile» 3 (2025) 2-6.[2] XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, Instrumentum laboris, 8 maggio 2017, n. 29.[3] Ivi, n. 30.[4] «In alcuni Paesi la fede cristiana è un’esperienza comunitaria forte e viva, che i giovani condividono con gioia. In altre regioni di antica tradizione cristiana la maggioranza della popolazione cattolica non vive una reale appartenenza alla Chiesa; non mancano però minoranze creative ed esperienze che rivelano una rinascita dell’interesse religioso, come reazione a una visione riduzionista e soffocante. In altri luoghi ancora i cattolici, insieme con altre denominazioni cristiane, sono una minoranza, che conosce talora discriminazione e anche persecuzione. Vi sono infine contesti in cui vi è una crescita delle sette o di forme di religiosità alternativa; coloro che le seguono non di rado restano delusi e diventano avversi a tutto quanto è religioso. Se in alcune regioni i giovani non hanno la possibilità di esprimere pubblicamente la propria fede o non vedono riconosciuta la propria libertà religiosa, altrove si sente il peso di scelte del passato – anche politiche –, che hanno minato la credibilità ecclesiale. Non è possibile parlare della religiosità dei giovani senza tenere presenti tutte queste differenze» (XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, Documento finale, 28 ottobre 2018, n. 48).[5] Ivi, n. 14.[6] Ivi, n. 49.[7] Ivi, n. 50.[8] Francesco, Esortazione apostolica postsinodale Christus vivit, 25 marzo 2019, n. 163.[9] Ivi, n. 158.[10] Cfr. 2Cor 4,7.[11] Francesco, Esortazione apostolica postsinodale Christus vivit, 25 marzo 2019, n. 35.[12] P. Wątor, La Pastorale Giovanile Cattolica negli Stati Uniti. Verso il suo rinnovamento a confronto e in dialogo con i modelli protestanti, LAS, Roma 2025.[13] Francesco, Udienza generale del 28 gennaio 2015.